La casa di Jack (2018): Recensione
La casa di Jack (2018): Recensione
La casa di Jack (titolo originale: The house that Jack built), recensione del film diretto da Lars von Trier con protagonista Matt Dillon. Uscito nelle sale francesi il 17 Ottobre 2018.
VOTO MALATI DI CINEMA 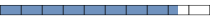 (8,5 / 10)
(8,5 / 10)
The house that Jack built è stato per diversi anni nella mia wishlist, fino a quando ieri ho deciso di vederlo.
Sono tre le matrici del sussulto che mi ha trattenuta dal premere Play:
-il genere thriller/horror. Oltre a non essere fan del genere, sono solita tenermene alla larga per paura.
-la fama. Il film è stato acclamato dagli addetti ai lavori come “il capolavoro” di Lars von Trier, per cui ho desistito dal consumarlo subito e ho preferito attendere il “momento giusto” per godermi il cult.
-la reazione del pubblico. Critici e redattori giornalistici che hanno assistito alla proiezione della pellicola al Festival di Cannes, hanno affermato che più di un centinaio di spettatori sono letteralmente “fuggiti dalla sala”, disgustati e gridando all’orrore e all’oscenità.
Insomma, diciamo che ho avuto i miei buoni motivi per desistere, fino a che la fama del capolavoro ha preso il sopravvento e ho ceduto.
Quindi, La casa di Jack è davvero il capolavoro del regista danese più controverso che conosciamo?
Secondo me no, e non è neppure il più iconico. Tuttavia è il prodotto cinematografico del regista più introspettivo e limato: costruito a regola d’arte.
Jack è un ingegnere ma ama definirsi architetto, e sta lavorando alla costruzione dei suoi sogni. Tuttavia ogni volta qualcosa va storto: la costruisce e la butta giù una, due, tre volte.
Jack è convinto che i materiali con cui si edificano strutture e architetture godano di una volontà propria in grado di determinare la resa finale dell’opera.
Jack è un serial killer, seleziona quasi con indifferenza le sue vittime, ma ha un debole per le donne che considera “stupide”.
Jack è uno psicopatico con un disturbo ossessivo compulsivo per la pulizia.
Jack è il protagonista della narrazione, che si sviluppa a due ritmi.
Il primo ritmo è scandito dal dialogo tra Jack e Verge, che oscilla tra una pseudo seduta psichiatrica e un serrato botta e risposta (degno di Piero e Alberto Angela) colto, filosofico, manicheistico. Arte, Dio, bene e male, amore, famiglia, leoni e agnelli sono solo alcuni dei temi esplorati.
La narrazione incalza nel secondo ritmo e muta in una meticolosa, psicotica, agghiacciante collezione degli omicidi commessi dal protagonista.
Jack è Matt Dillon, in quella che personalmente definisco la sua interpretazione più iconica, egregiamente accompagnato nel suo viaggio da Bruno Ganz nella sua ultima performance.
Jack e Verge altro non sono che le due anime del regista: l’ombra e la luce che, in tensione tra loro, si scontrano e cercano di avere la meglio sull’altra. Ed è proprio in questa complessità che si crea la vita e l’arte. von Trier dialoga intimamente con se stesso, superando ancora una volta i limiti imposti dal buon senso e dalla morale collettiva, infrangendo tutte le regole e toccando vette metafisiche altissime.
Il rapporto tra arte e morale si dissolve con l’accettazione della mostruosità insita nella natura umana e si fa sublimazione artistica. Così la scissione anima-corpo si risolve in un’originalissima teoria: l’inferno ospita il corpo, il paradiso accoglie l’anima.
Ora posso ammettere che durante le due ore e mezza di pellicola ho fatto il mio ingresso nel sistema valoriale creato dal regista e ho lasciato fuori la morale e l’etichetta umana. Le atrocità e le barbarie finiscono per diventare grottesche ai miei occhi, le situazioni surreali e disumane visione delirante e psicotica di una mente fortemente complessa. Ho adottato il punto di vista suggeritomi dai compagni di viaggio Jack & Verge (rivisitazione di Dante e Virgilio ne La Divina Commedia) e ho tralasciato le questioni morali: come siamo soliti fare dinanzi a un’opera d’arte, ci astraiamo dalle vicende umane lasciamo che il simbolismo prenda il sopravvento sulla realtà.

