The Grandmother (1970): Recensione
The Grandmother, recensione/analisi sul mediometraggio della durata di 34 minuti diretto da David Lynch nel 1970
VOTO MALATI DI CINEMA 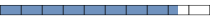 (8,5 / 10)
(8,5 / 10)
The Grandmother, mediometraggio della durata di 34 minuti girato da David Lynch precisamente nel 1970 grazie alla sovvenzione di 5.000 dollari dell’American Film Institute, è senza alcun dubbio la porta d’ingresso a quello che sarebbe stato l’onirico, delirante, allucinante ed illuminante cinema del regista di Eraserhead (1977), The Elephant man(1980), Blue Velvet (1986), Twin Peaks ( 1990 – 1991) e Mullholland Drive (2001).
Suppongo sia necessario comprendere in quale punto preciso della produzione filmica di Lynch si stanzia la creazione di The Grandmother. David Lynch nasce come pittore, frequenta infatti a Filadelfia la Pennsylvania Academy of Fine Arts dove proietterà, a fine anno accademico, il suo primo cortometraggio Six Figures Getting Sick; al principio, esso, non era altro che uno dei suoi dipinti; un dipinto,che nella geniale testa del regista, grazie ad un soffio d’aria, prese movimento.
Il secondo cortometraggio del regista è quello sul quale dobbiamo porre la nostra attenzione, determinante ai fini della creazione di The Grandmother. Il regista rivela infatti che quest’ultimo nasce proprio nel momento in cui si accinse a filmare The Alphabet (1968), cortometraggio che, per animazione, struttura ma soprattutto per temi, si pone quasi come un continuo del sopracitato.
The Alphabet è un viaggio lacerante, un viaggio nel apprendimento forzato del bambino, nelle tecniche mnemoniche demoralizzanti, nell’appiattimento delle filastrocche omologanti, nella pressione e nella corsa, nella quale il bambino si ritrova costretto a gareggiare per imparare a leggere come gli altri, nello stesso tempo degli altri, per non essere emarginato e considerato minore. Come spiega lo stesso Lynch, nelle interviste a capo di ogni corto nella collezione “The Shorts Films of David Lynch” (2002), il corto nasce da un incubo di Peggy (la prima moglie di Lynch), la quale diventerà anche interprete del corto, nel quale vedeva suo nipote chiuso in una “dark room”, “repeating the alphabet over and over in his nightmare”. Il gioco di forme astratte e asettiche, suoni alienanti ed estranianti (facili da rintracciare in quasi tutta la filmografia Lychiana), Peggy coperta in volto da un fondotinta bianco, che si contorce nel letto sputando sangue e cercando di afferrare le lettere che sfuggono. Lettere nere e bianche, non colorate e giocose, ma terrificanti, meccaniche. Un gioco perturbante questo di Lynch, nel quale si riscontra l’idea di un bambino al quale, fin dalla scuola primaria, viene sottratta l’individualità, viene negata la creatività, viene ucciso ogni suo istinto artistico ed innovatore, per conformarlo, omologarlo a tutti i suoi compagni, futuri uomini e donne, di un domani chiuso, prescritto e già deciso.
Ed ecco, che dopo “The Alphabet”, nel 1970, Lynch giunge a “The Grandmother”, oggetto della nostra analisi. Il mediometraggio viene girato nella casa del regista, dove, le pareti, per l’occasione, vengono ridipinte di nero. La narrazione non risulta estremamente complicata a primo acchitto: si racconta di una famiglia composta da un padre (Robert Chadwick), una madre (Virginia Maintland), il figlio ( Richard White) e infine l’ultima creata, la nonna (Dorothy McGinnis), dove i due genitori sono però due bestie che maltrattano il ragazzo ogni giorno, conducendolo alla disperazione e alla creazione di una amorevole nonna, che come per magia, nasce dai semi che il ragazzo pianta nel suo letto. La scena della creazione della nonna è molto suggestiva e a tratti terrificante: il bambino entra nella sua cameretta, trova un sacco con dei semi (sopra il quale giganteggia la scritta “seeds”), prende della terra, scava una fossa di terriccio sul letto, ci ripone i semi e comincia ad annaffiarli. Ed ecco che così spontaneamente avviene la genesi della nonnina pacioccona, sotto lo sguardo incredulo del bambino, che accarezza l’involucro di terra che fuoriesce dal letto, continuando con cura ad annaffiarlo ed accarezzarlo. Molteplici stacchi a nero, ci danno il passare del tempo, fino ad una pacifica ed infantile animazione di un cielo azzurro e un sole, che si contrappone alle urla del padre che richiama il bambino “Matt! Matt”, entrando bruscamente nella sua stanza, prendendolo dal collo e spingendolo sul materasso del letto, dove vediamo una vivida macchia gialla; la quale, a mio parere, non a caso, richiama l’animazione del sole appena visto, quasi come se Lynch volesse trasmetterci la assoluta naturalezza di un bambino che urina nel letto dalla paura, come se volesse dirci quanto sia naturale e incolpevolizzabile, soprattutto quando sono proprio i famigliari ad essere fonte dell’angoscia del bambino. Ancora un altro stacco a nero e ritorniamo dalla nonna-arbusto, che ormai spinge per venire al mondo; contrazioni meccaniche ed intermittenti mettono la nonna al mondo in una cascata di liquido amniotico. La nonna è accasciata a terra, quando Matt le porta dei fiori: una delle scene più toccanti e commoventi è la serie dei campo-controcampo dei due, mentre si guardano e un sorriso piano piano si forma nei loro volti per culminare in un abbraccio.


È necessario ora uno sguardo a quella che è la famiglia surreale del povero Matt, la scena del pranzo è senza dubbio la più analizzabile: i due sporchi figuri dei genitori, strafogano del cibo con le mani, mentre Mike fissa il pianto, inappetente e continuamente percosso dai due, che sfondando sonoramente il continuo sottofondo lamentoso, gridano il suo nome, unica parola pronunciata nel corto. Successivamente, la madre si alza dal tavolo, ma questa volta non scorgiamo il volto, che è totalmente oscurato, ma solo dal collo fino al dito puntato sul bambino mentre ancora stridulamente urla il suo nome; Matt rassegnato fugge in camera sua dove ritrova la nonna. È criptico, quanto vividamente chiaro ciò che Lynch vuole trasmetterci: le tue radici non sono necessariamente quelle che ti generano, ma quelle che ti amano, ti comprendono e ti stanno accanto, trasmettendoti fin da bambino la serenità che meriti.

Successivamente Lynch lascia un po’ di spazio all’animazione: Matt scappa su per le scale mentre i due genitori schiamazzano, un frame si blocca sulla sua faccia e dalla sua bocca fuoriescono dei fili rosso sangue, forse quei fili che dalla gola fino all’ombelico lo attraversano e lo legano a quelle due persone, che per lui non sono nulla, se non l’incubo di ogni sua giornata; l’animazione ci lascia infatti sotto intendere la voglia assassina del bambino che vorrebbe decapitare il padre e far colpire la mare da un grosso sasso.
Poi ritorna ancora nella cameretta, dove la nonna è seduta sulla bianca sedia a dondolo; da lontano si scambiano delle parole, che non udiamo, ma possiamo intravedere, grazie alla capacità grandiosa di Lynch di farci sentire quello che non è detto, e vedere quello che non è mostrato. La seguente è una scena da brividi, da occhi lucidi: i due si tendono un braccio, si tastano, si accarezzano per poi con occhi lacrimanti, scambiarsi un innocente e colmo di amore bacio in bocca.
Ma l’incubo confluisce in un incubo più grande, l’animazione ci riassume quello che vedremo da qui a poco: la dolce nonna vola via da una sorta di “evolution army” alla Twin Peaks; la nonna che con le mani al collo si perde d’aria e soffoca, immagini intermittenti e disturbanti la mostrano vagare per la stanza, mentre Matt cerca disperatamente aiuto dai suoi genitori che, indifferenti, fanno finta di nulla, lo deridono e lo scherniscono.
Siamo al termine di questo straziante e lacerante viaggio Lynchiano, stacco a nero, cambio di location, siamo ora in un arido campo, dove Matt scorge la nonna seduta sulla sua sedia a dondolo. Lo fissa, come per domandargli che cosa lo stia preoccupando così tanto e dopo, in un attimo, getta la testa all’indietro, spalanca la bocca e muore. Matt si getta a terra, urlando come se con lei, fosse morto anche lui. Ritorna nel suo letto, per dormire e rialzarsi il giorno dopo, rientrando nella distruttiva routine della sua casa nativa. Nell’ultimo frame c’è il bambino che al posto della testa ha un arbusto, circondato da radici, che sembrano spine pungenti, i suoi genitori, che non lo abbandoneranno mai.
