La strada (1954): Recensione
La strada, recensione del film diretto da Federico Fellini con protagonista Giulietta Masina. Uscito nelle sale il 23 settembre 1954
VOTO MALATI DI CINEMA 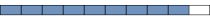 (9 / 10)
(9 / 10)
Il Matto: Io so ‘gnorante, però ho letto qualche libro. Tu ‘un ci crederai ma tutto quello che c’è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco prendi quel sasso lì, per esempio.
Gelsomina: Quale?
Il Matto [prendendo un sasso da terra]: Questo… uno qualunque. Be’, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto.
Gelsomina: E a cosa serve?
Il Matto: Serve… Ma che ne so io? Se lo sapessi sai chi sarei?
Gelsomina: Chi?
Il Matto: Il Padreterno che sa tutto… quando nasci, quando muori e chi può saperlo? No. ‘Un lo so a cosa serve questo sasso qui ma a qualcosa deve servire, perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Almeno credo. E anche tu… anche tu servi a qualcosa con la tu’ testa di carciofo.
Il nomade nerboruto Zampanò (Anthony Quinn) acquista la semplice ragazza Gelsomina (Giulietta Masina) dalla madre povera, affinché diventi sua moglie e lo assista durante il suo numero da saltimbanco. In sella ad uno sgangherato motocarro, i due attraversano le strade d’Italia che li condurranno verso cittadine provinciali e centri di campagna, vivendo alla giornata nella speranza di racimolare qualche soldo per campare. Nonostante la brutalità dell’uomo, che la costringerà a cucinare, pulire ed assolvere varie incombenze coniugali, Gelsomina rimane devota a Zampanò, anche quando il Matto (Richard Basehart), clown cordiale e impavido funambolo, la prende in giro dopo che la coppia si unisce ad una compagnia circense.

Fellini ha descritto le riprese di questa storia apparentemente semplice come una vera e propria odissea, che lo trascinerà alla fine in uno stato di completo esaurimento nervoso. L’attore Anthony Quinn la ricorda come un’esperienza stancante, sottolineando la pervivacia del regista nel girare scena dopo scena finché non avesse ottenuto ciò che voleva. In compenso, Quinn riconosce di aver imparato più sulla recitazione cinematografica in tre mesi col maestro riminese che in tutta la sua precedente carriera attoriale. La moglie di Fellini, Giulietta Masina, si è lamentata del fatto che il marito sia stato particolarmente severo con lei durante le riprese; occasione questa che ha dato adito a polemiche sul presunto maschilismo del regista, riflesso di una società che fatica a slacciarsi dall’atavico retaggio della predominanza del “sesso forte” e di cui la presente pellicola potrebbe costituire massima espressione. A ragion veduta, non è che fossero rimproveri del tutto sterili e infondati. Saranno gli anni successivi ad approfondire l’intrinseca concezione felliniana della femminilità: Anita Ekberg nell’iconica scena della fontana di Trevi ne “La dolce vita” (1960) e l’harem fiabesco in “8½” (1963) sono i paradigmi più immaginifici delle fantasticherie maschili sulle donne.
L’eroe Zampanò, possente e coraggioso ma tutt’altro che virtuoso, si scontra con un antagonista, il Matto, personaggio che presenta molti tratti comuni col tipico fool shakesperiano (si pensi a Touchstone in “Come vi piace”, Feste ne “La dodicesima notte”, il Matto in “Re Lear”, Autolico ne “Il racconto d’inverno”, ecc.); tutt’altro che sinistro, egli è tenero e gentile ed il suo unico “difetto” è essere birichino, spesso sfottente ma mai veramente cattivo. Le sue parole sono ora tracotanti – specie nei riguardi di Zampanò – poiché intrise di verità, ora riempite di elucubrazioni filosofiche che instillano forti aporie nella mente degli interlocutori.
Di certo Zampanò è lontano anni luce dall’eroe platonico, ma in lui c’è una bontà, una nobiltà forse derubata dal tempo e dalla società, che ne fanno un eroe agli occhi di Gelsomina. In effetti, lei non è né bella né affascinante, né un’eroina risoluta, eppure lui l’ha salvata dalla sua vita mortale e l’ha portata in un’avventura. Le vite di questi personaggi sono intrecciate nei modi più belli e tragici allo stesso tempo.

Le allusioni che Fellini trae dai i suoi personaggi e dalla società del tempo in cui vivono sono molto precise. Non ha paura di esplorare gli anfratti sociali più oscuri, così come quelli della mente. Eppure non li rende beckettiani: c’è umorismo, musica, nonché disperazione e violenza nel mondo di Fellini. E c’è anche malinconia e pathos, che si accenderanno dentro Zampanò e ne scuoteranno l’animo quando, ad un certo punto, dovrà affrontare la bestia dentro di sé. Si tratta di un particolare pathos maschile che verrà mutuato e rinsaldato successivamente in capolavori come “Toro scatenato” (M. Scorsese, 1980) e “C’era una volta in America” (S. Leone, 1984).
Il film prende forma attraverso gli occhi della maltrattata Gelsomina, mentre cerca con leggerezza di centellinare le piccole cose della vita nonostante gli insulti che riceve dal compagno di viaggio. Il regista infonde nel suo personaggio principale un’ingenuità che scintilla schiettamente quando trova la compagnia del Matto o abbraccia la vita all’interno del circo, donando a Gelsomina una spiritualità che non si dimentica dopo la fine del film. Gli occhi spalancati di Giulietta Masina e il suo grande sorriso avvolgono lo schermo in maniera non dissimile da Charlie Chaplin e Buster Keaton, tenendo lo spettatore incollato alla sedia e suscitando un florilegio di emozioni.
Fellini prepara un terreno sinuoso per raccontare la storia di persone che non contano nulla per la collettività, le ultime ruote del carro di una società satura di mille disparità culturali, politiche e socio-economiche. L’Italia dilaniata dalla guerra deve aver creato molti di questi Zampanò e Gelsomina e ciò non è passato inosservato sotto gli occhi di Fellini, che in qualità di regista di classe racconta una storia che altrimenti sarebbe rimasta sottaciuta.
Se il lavoro del cineasta riminese è un gioco di corpo, anima e mente (Zampanò, Gelsomina e Il Matto) è anche una profonda dichiarazione sul mondo del dopoguerra che il film ritrae, un paesaggio desolato in cui le anime e le menti del corpo politico sono state devastate dalla forza bruta del fascismo italiano.
I circhi pacchiani inscenati, benché smilze (e a volte affascinanti) imitazioni di forme d’arte più serie come la letteratura, il cinema e il teatro, ci ricordano l’affermazione satirica di Giovenale: «il popolo due sole cose ansiosamente desidera: pane e giochi circensi» (Satire, X, 77-81). Per Fellini, è chiaro, il circo della vita è solo una versione più grossolana delle vaste fantasie mitiche evocate dall’immaginazione, in particolare dalla sua.

A far da sfondo musicale alla storia si stagliano le meravigliose composizioni del maestro Nino Rota, la cui preziosa collaborazione con Fellini è stata una caratteristica distintiva di alcuni dei suoi film più noti (tra cui “La dolce vita”, “8½”, “Amarcord”, ecc.). L’indimenticabile ritornello di tromba di Gelsomina esprime un desiderio d’amore che tanto più accresce quanto più l’intreccio narrativo si fa complesso e drammatico.
Realizzato nel 1954, “La strada” è il film che segna la fine del neorealismo italiano (come forgiato e sviluppato da Rossellini, De Sica, Visconti, ecc.) e l’inizio di un realismo magico più soggettivo e guidato dalla fantasia (non senza critica dei marxisti, che già gridavano al tradimento di Fellini), caratterizzato da un immaginario florido ed uno stile narrativo surreale, che negli anni successivi sarà il biglietto d’ingresso del termine “felliniano” nel vocabolario della lingua italiana.
Eppure, c’è anche una connessione tra la svolta di Fellini e un altro tipo di cinema moderno in Italia: lo stile militante frammentario di Pier Paolo Pasolini, in cui due inquadrature, gesti o volti qualsiasi solo di rado scorrono e si armonizzano in maniera convenzionale.
Primo della trilogia della solitudine, che si sarebbe conclusa con “Il bidone” (1955) e “Le notti di Cabiria” (1957), “La strada” vinse l’Oscar per il miglior film in lingua straniera, due Nastri d’argento e un Leone d’argento, stabilendo finalmente la fama di Fellini nello scenario internazionale.
La semplice poesia de “La strada” condensa insieme allegoria cristiana, agitazione istintuale freudiana e tragedia pre-femminista (il personaggio della donna-bambina innocente che soffre in modo che altri, specie uomini, possano scoprire compassione e intuizione anticipa la carriera di Lars von Trier, in particolare la sua trilogia del cuore d’oro: “Le onde del destino” (1996), “Idioti” (1998) e “Dancer in the dark” (2000)).
Ciò che più tocca della pellicola è il ritratto semplice e onesto di due persone molto umane e insignificanti che cercano di guadagnarsi da vivere ai margini della società. Ma è anche la visione della vita attraverso gli occhi di una persona emotivamente ingenua che, sebbene alla mercé di un mondo indifferente e brutale, riesce comunque a vedere la bellezza, l’innocenza, l’umorismo. Dove la maggior parte di noi vedrebbe solo oscurità e disperazione.
