Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità (2018): Recensione
Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità, recensione del film diretto da Julian Schnabel con protagonista Willem Dafoe.
Uscito nelle sale italiane il 3 gennaio 2019
VOTO MALATI DI CINEMA 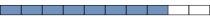 (8 / 10)
(8 / 10)
“Forse Dio mi fa dipingere per quelli che nasceranno: si dice che la vita sia fatta per seminare, e non è qui che ci sarà il raccolto”
Inizia tutto come non ci aspetteremmo: una voce fuori campo di un uomo che fantastica su un momento conviviale, la semplicità di un desiderio di inclusione, del calore di un rapporto umano. Il punto di vista del protagonista: da subito, in questa armonica pellicola biografica del periodo provenzale di Van Gogh, cogliamo l’intenzione della regia: scavare. Tra i ricordi, tra i legami, tra i luoghi. Quei luoghi tanto significativi, e non simbolici, genuini, e non artificiosi, che sono stati oasi e patibolo per uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Per lui e per la sua immensità, così incompresa e così ingombrante che ben ci comunicano gli occhi di Willem Dafoe. Quelle distese di campi che lo fanno pensare all’eternità e che gli fanno dichiarare “L’esistenza non può non avere una ragione”.
Un Van Gogh nel pieno flusso creativo, ma già respinto dai costumi, dal gusto. Rifiutato dai più, ma amato e accolto dal fratello, commerciante d’arte che provvedeva al sostentamento di Vincent e della cui approvazione l’artista fu sempre in cerca. Come se il successo e il consenso potessero sanare il dolore di un uomo malato, e per questo incompreso e discriminato, solo. Schernito da grandi e bambini, che presto lo spinsero a imboccare le corsie preferenziali per il manicomio. Ma lui non rinnega sé stesso, vede chiara la sua strada e ne sposa la causa, con oneri e onori. Ecco perché nel film vediamo toccato il tema delle radici, elemento che gioca un ruolo fondamentale nell’arte del pittore e che forse vogliono rappresentarne l’identità, il legame con i propri affetti.

Un uomo che scivolava costantemente tra visioni e realtà, attaccandosi alla mano di quei pochi capaci di mostrargli sincero affetto. “Il Folle” malvoluto da tutto il paese, scontroso, poco galante, sempre sporco e senza un soldo. Il visionario incapace di riconoscere cosa valesse davvero la pena di chiamare arte, e come distinguerla dalla follia. Van Gogh era tutto questo e tanto, troppo di altro. Eppure era proprio la pittura la sua miglior medicina, il “controveleno” il “parafulmine” contro il suo male, i suoi vuoti di memoria, le sue domande interiori. Sorprende come, per tutto il corso del film, seppur la malattia del pittore avanzi, di pari passo si sviluppi un’autoanalisi crescentemente lucida. Quella lucida consapevolezza che culminerà, come sappiamo dalla sua storia, con la lettera spedita a Theo pochi giorni prima della morte.
Una morte annunciata, che volenti o nolenti sappiamo già di doverci aspettare fin dalle prime scene. Eppure niente, in questo film, ci fa mai davvero percepire l’oscurità dell’aldilà. Nemmeno una singola scena, neanche un’inquadratura. Raramente si vede un racconto che ha come suo inesorabile e noto finale la morte, schivarne l’ombra con tanta naturalezza, cedendo il passo a così tanta vitalità. Van Gogh ci parla dei suoi sensi interrotti, delle visioni e dei fantasmi, ma noi stiamo lì ad ascoltarlo e ci sentiamo a un passo dalla prossima inquadratura di un paesaggio luminoso.
Ci sentiamo come disarmati dalla violenta armonia con cui ci travolge quella cascata di luce, quel giallo intenso, quei colori che gridano vita. Gli stessi che animavano i suoi dipinti e di cui andava alla ricerca costantemente, nella Francia del sud, come un “esule”, un “pellegrino”. In un dialogo con il prete che deve valutarne i progressi per eseguirne una perizia psichiatrica, Van Gogh parla di sé stesso come di Gesù: anch’egli era stato schernito, escluso e mandato al patibolo, anche lui fu riscoperto solo alcuni decenni dopo la sua morte. Ed è nel suo annunciarsi precursore in una formula disarmante di follia e lucidità, che Vincent Van Gogh provò a comunicare al mondo l’intuizione più grande: la sua visione al di sopra d’ogni “schermo”, l’apoteosi sensoriale della realtà, celata nel colore e nella sua più nuda semplicità. La sua immensa eredità.
