La grande abbuffata (1973): Recensione
La grande abbuffata, recensione del film scritto e diretto da Marco Ferreri nel 1973. Uscito nelle sale italiane il 7 dicembre 1973
VOTO MALATI DI CINEMA 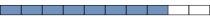 (8 / 10)
(8 / 10)
C’è una deriva infantile nella sessualità dei quattro protagonisti de La Grande Abbuffata: Ugo, Michel, Philippe e Marcello. Che oltre a essere simboli della società borghese dell’epoca sono anche archetipi di una libido maschile ludica e dissacrante. Il piacere edonistico, giocoso e senza tabù, viene sublimato dalle abbondanti e materne forme di Andrea, la quale, in un misto di pietà e accondiscendenza carnale, accompagnerà i quattro amici verso il loro suicidio gastronomico. La ricchezza dei cibi, delle portate, pieni di colori e fantasia si scontra con i freddi e algidi esterni della villa parigina dove questi uomini decidono di mettere in scena la loro morte. All’interno dell’abitazione si partecipa ad un teatro della crudeltà gastrointestinale, con costumi e stanze a tema, dove il culto del cibo alimenta performance votate ad un sublime masochismo viscerale.
Sembrano non esserci rimorsi o sfondi morali per questa scelta di annichilimento corporeo, contornata dai ruggiti del motore di una Bugatti o dalle poderose flatulenze del culo di Michel, sonorità dirompenti che frantumano le poche note musicali suonate su un pianoforte, i gemiti prodotti dagli orgasmi e quelli partoriti da digestioni incomplete. Si spezza così una continuità verbale che sono i dialoghi a costruire, pieni di spudorate e ironiche vanità fallocentriche, che delineano il mondo in cui questi uomini hanno vissuto e dal quale hanno deciso di scomparire.
Immagini erotiche proiettate su un muro, fotografie di donne seminude, lingue saettanti, atti sessuali che deviano l’individualismo borghese in un collettivo orgiastico che disintegra ogni possibile convenzione sociale. Marco Ferreri, nobilita nella trasgressione e allo stesso tempo divora in un macabro surrealismo i suoi attori attraverso serie ininterrotte di invenzioni feticistiche e succulente perversioni. È dunque in Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini la parte scatologica mancante di questa pellicola? Che, fatta eccezione per la scena dell’esplosione di un cesso, non mostra dove tutto questo cibarsi e divorare andrà a finire. Perché l’implosione (personale e sociale) non è rivolta al sistema ma solo un onanistico privilegio di morte di una classe e dei suoi appartenenti ormai senza più desideri o scopi esistenziali. Cosa ne è stato, allora, delle feci del consumismo, del capitalismo e della borghesia? Dove è andata a finire tutta questa merda? A più di cinquanta anni di distanza dall’uscita della pellicola basterebbe darsi un’occhiata intorno per trovare una risposta. E in molti, ancora, non ne hanno avuta abbastanza.
