La casa dalle finestre che ridono (1976): Recensione
La casa dalle finestre che ridono, recensione del film diretto da Pupi Avati. Uscito nelle sale cinematografiche il 16 agosto 1976
VOTO MALATI DI CINEMA 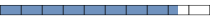 (8,5 / 10)
(8,5 / 10)
Stefano (Lino Capolicchio) viene ingaggiato dal Solmi (Bob Tonelli), sindaco di un paesino del ferrarese, per restaurare un affresco raffigurante il martirio di San Sebastiano.
L’opera è stata realizzata anni prima dal pittore pazzo Buono Legnani (Tonino Corazzari), morto suicida, anche noto come il “pittore delle agonie” per la sua inclinazione a raffigurare persone prossime alla fine.
Poco prima di iniziare i lavori, Stefano viene avvertito dall’amico Antonio Mazza (Giulio Pizzirani), che ha caldeggiato il suo intervento come restauratore, di alcuni misteri che riguardano l’affresco. Antonio, tuttavia, muore in un finto suicidio prima di poter entrare nei dettagli.
Stefano, quindi, decide di indagare da sé. E nel far ciò, incontra l’ostilità dell’intero paese, sostenuto, in un crescendo di emozioni e colpi di scena, soltanto dalla giovane maestra Francesca (Francesca Marciano), sua amante, e dal Coppola (Gianni Cavina), autista di piazza alcolizzato, custode di un terribile segreto.
La verità che a poco a poco emergerà sarà assolutamente sconvolgente.

Reduce dall’insuccesso del suo quarto lungometraggio Bordella, Pupi Avati realizza, con un budget risicatissimo e con una troupe di soli 12 elementi, un thriller-horror di pregevole fattura traendo spunto dalla favolistica nera contadina.
L’autore si ispira, in particolare, alla leggenda del “prete-donna” direttamente appresa da bambino ai tempi della guerra: “Io ero a Sasso Marconi, ero sfollato e mi veniva raccontata la storia de “La casa dalle finestre che ridono” […] Era la storia di un cimitero di San Leo dove vennero riesumate le tombe per risistemarle. E, nel riesumare la tomba del vecchio parroco, si accorsero dallo scheletro che si trattava di una donna. E allora, da quel momento, si sparse nella zona la diceria che potesse di notte appalesarsi un “prete-donna” […]”.
Ambientato nella bassa padana placida e soleggiata, popolata da personaggi pittoreschi e accoglienti, La casa dalle finestre che ridono, rifugge nelle premesse dai topoi foschi e inquietanti del genere. Ma è solo apparenza.
Non appena ci si addentra nella storia – blandamente cadenzata – ci si accorge, infatti, che dietro l’aspetto rassicurante di un microcosmo quieto si nascondono collusioni, misteri, insidie.
La provincia, quindi, non è il luogo sonnacchioso e ameno affidato ai soliti cliché.
Il male – sembra suggerire Avati in una sorta di ribaltamento dell’immaginario comune – si nasconde dappertutto, anche dentro casa.
Pervaso da un senso di inquietudine che aumenta col progredire del racconto, il film beneficia di un climax ascendente lento e inesorabile che tiene incollato lo spettatore alla poltrona per tutto il tempo e che culmina in un finale sconcertante e geniale che di per sé vale l’intera visione.
Non influiscono sul valore complessivo dell’opera né alcuni passaggi narrativi eccessivamente ellittici, né le scene d’amore tra Stefano e Francesca, troppo “scollate” dal resto del racconto.
Assolutamente funzionali alla narrazione, invece, risultano l’uso “chirurgico” degli effetti sonori, la fotografia dai toni caldi di Pasquale Rachini, nonché le musiche suggestive di Amedeo Tommasi.
Buona la prova d’attore di Capolicchio, elegante, ingenuo, caparbio, sebbene la parte del leone qui la faccia Gianni Cavina (sua è anche la voce del Legnani), davvero intenso e commovente nei panni dell’alcolista tormentato.
Dirige il tutto un ispiratissimo Avati, impeccabile nella scelta delle inquadrature, nell’attenzione per i volti e nel tenere alta la tensione di un racconto complesso.
Tra le curiosità, va ricordato che per la parte di Francesca, il regista bolognese aveva pensato a Mariangela Melato. Lo stesso Capolicchio, inoltre, avrebbe dovuto essere il protagonista di Profondo rosso di Dario Argento, film da sempre considerato “attiguo” al lungometraggio di Avati e con questo da molti ritenuto il miglior thriller all’italiana di sempre.
Per ammissione di Avati, si sarebbe dovuto trattare di un piccolo film “di recupero” e invece, grazie anche ad una sceneggiatura intricata e accattivante – realizzata dal medesimo regista unitamente al fratello Antonio, a Maurizio Costanzo e a Gianni Cavina – La casa dalle finestre che ridono si è rivelato un autentico capolavoro che ha dato vita, a sua volta, al sottogenere del cosiddetto “gotico padano”.
E ancora oggi, a distanza di più di quarant’anni dalla sua realizzazione, il film rimane a suo modo insuperato.
La casa dalle finestre che ridono resiste al passare del tempo grazie alla sua onestà, all’assenza di espedienti narrativi, allo “scavo” psicologico che porta ognuno dritto al centro delle proprie paure negandogli ogni certezza sublimata negli stereotipi, nei luoghi comuni: non esiste alcuna sicurezza, non si è mai completamente in salvo. Nulla è come sembra.
Inappuntabile, da ultimo, la scelta di un finale aperto, sospeso, che sembra voler invitare lo spettatore a spingersi al di là delle proprie inquietudini, laddove la paura stessa diventa motore dell’immaginazione e genera – per dirla con lo stesso Avati – “un’educazione al fantastico, all’immaginare che la realtà strabordi continuamente nell’irreale”.
Da culto
