Mindhunter (2017): Recensione
Mindhunter, recensione della Serie TV basata sul libro Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit. Distribuita da Netflix a partire dal 13 ottobre 2017
VOTO MALATI DI CINEMA 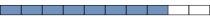 (8 / 10)
(8 / 10)
«Io che passo dal tristo scalpello anatomico alla fredda e severa analisi della storia, mi sento tratto scappare il proponimento inamovibile e mi vien voglia di abbandonare la vita del pensiero per quella del poeta.» (Cesare Lombroso)
Più o meno tutti gli appassionati di omicidi, sequestri di persona e crimini violenti sono cresciuti con Criminal Minds. Io per esempio ero molto affascinato da questa serie perché ogni episodio conteneva un caso nuovo da risolvere. Proiettandomi nelle vesti di agente investigativo, studiavo la ricostruzione del caso e provavo ad anticipare l’epilogo della vicenda delittuosa. Insomma, si tratta del classico whodunit che si completa (lo dice anche il nome) con i caratteri più pregnanti del whydunit. Come? Perché? Perché il cattivo ha ucciso quella persona? Perché l’ha fatto strangolandola piuttosto che esplodendo un colpo di pistola? Come ha perpetrato il reato, programmandolo in maniera scrupolosa o commettendolo passionalmente? Questi sono gli interrogativi che, seppur goffamente, Criminal Minds ha tentato in quindici anni di sopire. I crime shows sono un affare da miliardi di dollari, ma la maggior parte di essi esiste per confortarci. Alla fine il cattivo viene catturato e assicurato alla giustizia. Questo è uno dei motivi per cui spettacoli del genere sono così affidabili e riscuotono molte audiences: alle persone piace la conclusione, il lieto fine.

Ma nel mondo reale non sempre accade ciò. Ed è per questo che ritengo Mindhunter una serie geniale. Che sfida gli schemi della narrazione tradizionale, accettando l’ignoto con un incedere ritmico che mi ricorda Zodiac (D. Fincher, 2007). Basata sul libro “Mindhunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit”, la grintosa serie delinea la nascita e i primi passi della psicologia criminale in America e rappresenta alcuni degli omicidi più efferati del paese. Tuttavia, come indica il titolo, lo spettacolo esplora la mente dietro questi crimini, lasciandosi alle spalle sangue, sparatorie ed inseguimenti. Predilige gli orrori psicologici, anziché inscenare il crimine nudo e crudo.
Siamo a Quantico, in Virginia: all’Accademia dell’FBI militano i due agenti speciali Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), che dirigono l’unità di scienze comportamentali. La storia è fondata sulle esperienze di vita dell’agente dell’FBI John E. Douglas (che ha anche scritto il libro), dedicatosi, attraverso ampie interviste ad personam, alla descrizione dettagliata ed alla “profilazione” di alcuni degli assassini più spietati.
Ambientata tra il 1977 e il 1980, la prima stagione segue le vite dei due agenti che, avventurandosi in prigioni che sembrano roccaforti medievali, creano una base per profilare alcuni dei più grandi serial killer tra cui i rinomati Charles Manson, John Wayne Gacy, Richard Speck, James Earl Ray, Dennis Lynn Rader. Ma anche il meno noto Edmund Kemper (interpretato da un brillante quanto cinico Cameron Britton), che sarà per Ford fonte d’ispirazione. Gli farà capire che, grazie allo studio del loro modus cogitandi e operandi, a parlare con gli assassini seriali c’è solo da guadagnare.
Mindhunter segue l’agente Ford mentre esplora le teste degli assassini, studiando nel dettaglio (a tratti ossessivamente) le loro risoluzioni psichiche dai tratti contorti. Man mano che percorre i sinuosi sentieri della mente, egli diventa straordinariamente esperto a risolvere nuovi casi, riconoscendo l’importanza di indizi apparentemente irrilevanti e marginali. Ma a volte i suoi superiori non possono accettare i metodi estremistici di Ford, disapprovando l’idea di comprendere gli assassini attraverso l’uso della psicologia. In effetti, Ford non sta solo usando tecniche di profilazione comportamentale (oggi a noi così familiari), ma è il vero e proprio pioniere del criminal profiling.

Dal temperamento contrastante, il collega Bill Tench rimane sconcertato, disgustato. Ma al contempo risoluto nello svolgere il suo lavoro perché convinto che ciò che fanno in futuro servirà a qualcosa. Benché partner fedele di Ford, anch’egli di tanto in tanto nutre dei dubbi. Fino al punto di spegnere l’entusiasmo romantico di Holden che, tra citazioni di Dostoevskij, Freud e Shakespeare, tenta invano di instillare negli interlocutori un profondo insegnamento: diffidare da un rigoroso tecnicismo e da uno scientismo esasperato. Come Lombroso, così anche Holden vorrebbe metter da parte il “tristo scalpello anatomico”, “abbandonare la vita del pensiero per quella del poeta”. Perché per quanto gli astratti teoremi e i rigidi protocolli possano essere attendibili e verosimili, c’è sempre un punto dove la scienza non può arrivare. Intuizione, empatia, sesto senso, intimità, fiuto, confidenza: queste le armi per insinuarsi nelle logiche mentali (se esistono) dei serial killer, decifrandone i codici della personalità. Quello di Ford è un monito a “familiarizzare” con le dinamiche soggettive del delinquente; solo dopo è possibile ricostruire coerentemente il fatto di reato. Del resto, le rivoluzioni dei metodi investigativi sono merito proprio di Arthur Conan Doyle e Edgar Allan Poe.
Mentre i due agenti iniziano gettare le basi della propria metodica, lo spettacolo traccia magistralmente parallelismi tra le loro vite personali e professionali. Man mano che le cose si fanno più aspre, vengono affrontati con efficacia i principali tabù degli anni ’80, come l’ansia sul posto di lavoro, il razzismo e l’omofobia. Anna Torv (ex star di Fringe) interpreta la meravigliosa Wendy Carr, una professoressa di psicologia senza fronzoli che si unisce alla squadra dei due uomini.

David Fincher ha diretto complessivamente sei episodi – sarà seguito dal neofita televisivo americano Andrew Dominik e dal veterano televisivo Carl Franklin – ed è ancora invaghito dell’idea di concentrare la maggior tensione possibile intorno alla minima azione (in tal senso riprende Seven, Zodiac, Millennium – Uomini che odiano le donne e Gone Girl – L’amore bugiardo). Ci sono scene in squallidi uffici, illuminati da luci fluorescenti: Messerschmidt porta avanti con perizia una guerra ai colori primari, dipingendo lo schermo con una minacciosa tavolozza di smeraldo, tortora, marrone melma e nero abissale. Una successione di sequenze sconvolgenti ma esteticamente indistinguibili se non per l’inconfondibile inquadratura di Fincher, il nervosismo del montaggio Kirk Baxter e la colonna sonora di Jason Hill che resiste costantemente alla melodia.
Mindhunter è un’opera sul processo, sulla metodologia. E, in una qualche misura, sulla scienza. Su come ricercatori ed esperti hanno cominciato ad approfondire e complicare i loro (e quindi i nostri) concetti di patologia criminale. Ma si tratta anche di qualcosa di più ineffabile: il modo in cui siamo attratti dall’oscurità, affascinati, perseguitati, presi in giro dal lurido e dall’impensabile. Forse lo spettacolo sta profilando anche noi.

Gli spettatori godono del brivido malaticcio di essere perseguitati, persino tormentati dalle manipolazioni esperte di Fincher. Ogni episodio si conclude con il team dell’FBI che apprende qualcosa prima sconosciuto sulla mente omicida, eppure lascia residuare ancora domande, spesso più dubbi di prima. Dubbio che l’assassino non sia scappato; dubbio che possiamo veramente conoscere i nostri partner o figli; dubbio che possiamo mai essere certi del divario tra noi e il lato oscuro. Ci costringe a chiederci: cosa sappiamo sull’omicidio, sulla psicologia, sulla legge, sull’ordine? Perché gli assassini prendono souvenir? Perché tornano sulla scena del crimine? Perché scrivono lettere e si danno dei nomi? E perché alcune vittime diventano assassini?
Se sei un vero drogato di criminalità, con un debole per gli omicidi ed affamato di conoscenze psicologiche, questa è proprio la serie che fa per te. Mindhunter non è solo un viaggio affascinante negli incubi criminali, ma anche un balsamo rassicurante per la paura che questi incubi incutono.
E se fossimo tutti nell’abisso, armeggiando nell’oscurità, senza essere mai del tutto sicuri di ciò a cui possiamo aggrapparci?
