Halloween (2018): Recensione
Halloween, recensione del film diretto da David Gordon Green e sequel diretto del film di John Carpenter del 1978 ignorando, di fatto, i sequel precedenti. Uscito nelle sale italiane il 19 ottobre 2018
VOTO MALATI DI CINEMA 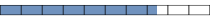 (7,5 / 10)
(7,5 / 10)
È il 1978 quando, grazie all’omonimo film diretto dal trentenne regista di New York John Carpenter, il pubblico italiano comincia a familiarizzare con Halloween, festività del folklore celtico risalente dall’antica ricorrenza pagana di Sam-hain. Per gli amanti del genere, il plot della pellicola è ormai un classico. Nel 1963, ad Haddonfield, nell’Illinois, durante la vigilia di Ognissanti l’adolescente Judith Myers viene uccisa a coltellate dal fratellino Michael, di soli sei anni. Preso in cura dallo psichiatra Sam Loomis, Michael Myers trascorre i successivi quindici anni rinchiuso nel manicomio criminale di Smith’s Groove, da cui fugge per tornare alla casa natale (ormai in decadenza e messa in vendita), quasi fosse alla ricerca del genius loci malvagio che si nasconde in quel luogo. Siamo alla vigilia di Ognissanti, la notte di Halloween, e dall’inevitabile strage di innocenti che segue (compiuta da Michael con indosso una maschera che ricorda quella della protagonista di “Gli occhi senza volto” (1960), chiaro omaggio al regista francese Georges Fanju), riesce miracolosamente a salvarsi la giovane baby sitter Laurie Strode. Il film decreta la nascita dei cosiddetti “slasher movie” e l’immediata ribalta per John Carpenter, ideatore del soggetto insieme a Debra Hill, nonché autore della colonna sonora. Da quel momento inizia una vera e propria saga, con nove successivi episodi diretti da differenti registi che nulla aggiungono all’idea originaria.
A distanza di quarant’anni, con la supervisione dello stesso regista newyorkese, David Gordon Green (“Strafumati”, 2008, “Joe”, 2013) riprende il filo interrotto dopo quella proiezione originaria azzerando tutti i sequel e i remake. Per donare verosimiglianza al tutto, ripropone alcuni degli interpreti di allora (da Jaime Lee Curtis a Nick Castle) adottando come pretesto narrativo per riaprire e, forse, chiudere il cerchio, la passione di due giornalisti investigativi per i delitti famosi accaduti nel passato, passione che li spinge a incontrare il carnefice e la vittima scampata al famoso eccidio avvenuto in quella lontana vigilia di Ognissanti.
Ritroviamo allora Michael Myers internato allo Smith’s Grove Sanitarium (“Quarant’anni senza dire una parola, sa parlare ma ha scelto di non farlo”, sentenzia il dottor Sartain, l’allievo del defunto dottor Loomis che ora ha in cura Michael), rappresentante reale e metaforico di quel “male assoluto” che è la definizione che di lui aveva dato proprio il dottor Loomis. Gordon Green ritrae Michael di spalle, immobile, ritirato nelle risonanze profonde all’interno di se stesso, una forma di vita più che un essere umano, un misto animalesco di ferocia e desolazione.

E rivediamo l’ex baby-sitter Laurie Strode. Agorofobica, sotto terapia cognitiva, apprendiamo che è diventata nonna e che vive in una casa bunker, con un locale sotterraneo pieno di armi e trappole, riflesso di una mente scivolata in una dimensione di paranoia. Ma è paranoia, quella sorta di pulsazione che picchietta nella sua mente? (“Quindi è reale, l’Uomo Nero?” chiede a un certo punto Laurie ai due giornalisti riprendendo il filo interrotto quarant’anni prima nell’ultima scena dell’”Halloween” primigenio, e alla risposta evasiva di Korey, replica: “Lei non crede all’Uomo Nero? Invece dovrebbe”). O non è, piuttosto, consapevolezza dell’ineluttabile presenza del male? Già: la consapevolezza. Uno stato mentale che brucia e che fa terra bruciata intorno a sé, ma che è il prezzo da pagare per riprogettare il proprio ruolo nel copione della vita. “Se ho cresciuto male mia figlia preparandola agli orrori di questo mondo, a me sta bene”, afferma Laurie, e sono parole che fanno da contrappunto all’ingenuo candore della figlia Karen, che pare non voler trarre insegnamento dall’eredità emotiva della madre quando sentenzia: “il mondo non è un buco nero e malvagio, ma un posto d’amore”, quasi fosse il leibniziano migliore dei mondi possibili, mentre in sottofondo risuona, beffardamente volterriana, l’iconica suonata al pianoforte al ritmo di 5/4. Quando poi il trasferimento di Michael in un altro penitenziario segna l’inevitabile svolta slasher della pellicola, con recupero dei classici strumenti iconografici – coltellaccio e maschera – la successiva carneficina di prammatica è quasi una sorta di allenamento svolto con un’urgenza squisitamente rituale. L’assassino che si aggira indisturbato fra le case di Haddonfield, maschera fra le maschere in un Halloween calato nell’era social (con baby-sitter attaccate agli smartphone e bambini impegnati a chattare), se da un lato strizza l’occhio alla parodia dell’horror mostrando le cose non per quelle che sono o che ci si aspetta che siano, dall’altro risulta però funzionale per rappresentare la minaccia che costeggia la nostra quotidianità, simboleggiata dal Boogeyman. Lui sì, immutabile. “Sopprimerlo è l’unica soluzione, non c’è alcun motivo per tenere in vita il male” aveva dichiarato in una vecchia intervista il dottor Loomis. Il suo allievo lo sa bene, ma vuole andare oltre, Sartain, perché la fascinazione del male ha ormai attecchito, su di lui, ossessionato, lo psichiatra, sia dall’effetto che producono i crimini sul perseguitato, sia da quello che prova il persecutore nell’uccidere. “Predatore e preda si alimentano tenendo in vita entrambi”, afferma. Ed è proprio questa sorta di transfert blasfemo il cuore pulsante del film e la ragione per cui, crediamo, John Carpenter abbia officiato al rito di riesumazione di Michael Myers e Laurie Strode, riapparsi a ruoli invertiti nel più classico scambio delle parti fra vittima e carnefice. E quando infine la famosa scena conclusiva del film originale viene ribaltata, perché ora è Laurie e non Michael a sembrare immortale, appare chiaro che nell’eterna lotta fra il Bene e il Male, concordia e discordia, positivo e negativo si confondono fino a sovrapporsi. E se la consapevolezza dell’ineluttabilità del male (che è anche accettazione dell’ombra, della parte oscura di sé) ha permesso a Laurie di sopravvivere alle cose che accadono e di intravedere una luce in fondo al tunnel delle sue paure inconsce, ora che anche figlia e nipote hanno tratto coscienza in differita delle presunte ossessioni della nonna, la domanda che fluttua nell’aria è se sarà affidato proprio a loro, alle donne, alla loro alleanza, il compito di ribellarsi a una violenza declinata in forma sempre più impersonale.
Dall’ultima sequenza parrebbe di sì, e sembra di intravedere una piccola alba di significato all’interno dell’oscurità.
È un buon film di genere, l’”Halloween” di David Gordon Green, anche se lontano dall’eguagliare il particolare climax di suspense che accompagnava i cento minuti di proiezione del primo episodio (non si ha mai veramente l’impressione che stia per accadere qualcosa che non ti aspetti). Senza alcuna pretesa di originalità, il quarantatreenne regista americano cerca di innervare l’abituale dimensione slasher sfiorando alcune tematiche accattivanti, che permettono alla pellicola di non deludere i numerosi fans di John Carpenter, preservando l’immaginario iconografico nato in quella vigilia di Ognissanti del 1978.
